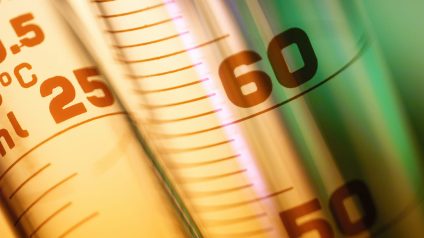Parla Grammenos Mastrojeni diplomatico e Coordinatore per l’Ambiente della Cooperazione allo sviluppo: ha scritto “Effetto serra: effetto guerra” per Chiarelettere (2017) dimostrando come cambiamento climatico e conflitti siano intimamamente connessi.

«Bene le prese di posizione dei governi sul cambiamento climatico ma serve mobilitazione collettiva: la natura non reagisce ai “pezzi di carta”»
(Rinnovabili.it) – Il Pentagono, quartier generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ha recentemente stabilito come il cambiamento climatico acceleri situazioni di instabilità portando ad estreme conseguenze (conflitti) situazioni difficili e già provate da crisi interne o indebolimenti. La connessione fra il cambiamento climatico e lo scoppio delle guerre è anche il tema del libro di Grammenos Mastrojeni e Antonello Pasini pubblicato da Chiarelettere: “Effetto serra: effetto guerra”.
Di questa connessione tra clima e guerra ne abbiamo parlato con Mastrojeni, diplomatico e Coordinatore per l’Ambiente della Cooperazione allo sviluppo.
Cambiamento climatico e scoppio di conflitti sembrano due tematiche apparentemente distanti ma leggendo “Effetto serra: effetto guerra” si scopre che è l’esatto contrario.
«Da sempre c’è un legame fra stato dell’ambiente e stabilità delle società: si è manifestato anche in tempi lontani (tra l’anno 400 d.c. e l’anno 1000) con delle fluttuazioni spontanee, ad esempio legato ad un periodo di raffreddamento in Asia centrale, connesso ad un aumento del 200% dei conflitti. Le stesse ‘invasioni barbariche’, così come siamo soliti chiamarle, che hanno portato al crollo dell’Impero Romano d’Occidente, sono state sospinte all’origine da alcune fluttuazioni climatiche. La questione è che con l’influsso umano la scala cambia: sia in termini temporali (le fluttuazioni diventano più rapide ed improvvise), sia in termini volumetrici del cambiamento, dunque l’effetto viene esacerbato. Attualmente, secondo ricerche condotte dal G7 (dunque non da ‘circoli ambientalisti’) tramite alcuni think-tank, risultano in corso 79 conflitti che hanno il cambiamento climatico tra le concause. Come avviene tutto ciò è abbastanza ovvio: non è tanto il fatto che con il cambiamento climatico arrivino dei fenomeni estremi, non è neanche il fatto che vi sia più penuria di risorse, ma è dato dal fatto che il comportamento della natura diventa imprevedibile e, di conseguenza, nell’imprevedibilità non si può organizzare né la produzione agricola, né la convivenza civile, perché entrambe le cose sono fondate sui ritmi della natura».
Il fattore dell’imprevedibilità, dunque aggrava notevolmente un quadro già destabilizzatosi?
«Certo, destabilizza le società, soprattutto quelle più fragili: quando queste si ‘disorganizzano’ il conflitto aumenta di probabilità».
Tutto quello che ha detto ci riporta all’attualità e al continente europeo: può essere considerata come ‘globale’ la partecipazione militare dei paesi della Nato (dunque anche dell’Ue) a dei conflitti spesso causati anche dal cambiamento climatico fuori dai confini occidentali?
«La caratterizzazione del conflitto, in realtà, è data dalla situazione di fatto. Di globale dobbiamo temere una tendenza alla saldatura delle differenti zone di destabilizzazione. Fino ad ora il Pentagono ha definito il cambiamento climatico come un acceleratore di conflitti, dunque non una causa, ed è vero: laddove è presente una società fragile, se “ci si mette” anche il mutamento del clima, la situazione contribuisce a creare un conflitto. Per ora queste fasce di fragilità sono relativamente isolate le une dalle altre. L’esacerbarsi dei cambiamenti climatici e il fatto che l’instabilità che nasce in zone povere si trasmette a catena nelle zone circostanti (e anche più lontane) fa sì che la situazione diventi ingovernabile.
Pensiamo ad un conflitto che ha tra le cause dello scoppio anche quella climatica, ovvero la guerra in Siria: ha portato a una catena di conseguenze a partire dalle migrazioni, che a loro volta, hanno avviato un principio di destabilizzazione – fra virgolette – in Europa. Da quel momento si è iniziato a voler ritrattare Schengen e si è cominciato un dibattito sulle responsabilità delle migrazioni fra Stati. Tali irradiazioni, così facendo, inizieranno ad intrecciarsi e si andrebbe verso uno scenario di destabilizzazione sistemica collocato non troppo in là nel tempo: il turning point è al 2030».
>>Leggi anche: Il riscaldamento globale causa guerre e conflitti: lo dice la statistica<<
Se, per caso, dovesse verificarsi un evento naturale imprevedibile, come diceva prima, il turning point scenderebbe ulteriormente?
«C’è un esempio che ho citato anche nel libro: se si dovesse verificare lo scioglimento del ghiacciaio dell’Himalaya si andrebbe incontro ad una situazione che metterebbe in movimento più di un miliardo di persone, l’evento avrebbe un carattere decisamente globale».
Le migrazioni connesse alla guerra in Siria, che prima ha citato, e quelle scaturitesi all’indomani della guerra in Libia, possono essere chiamate ‘migrazioni economiche’ o, secondo lei, ‘migrazioni climatiche’?
«Innanzitutto c’è bisogno di serietà su questo argomento: non c’è un’unica causa scatenante e sono molteplici, dunque è tutto ‘multifattoriale’ ma i cambiamenti climatici hanno – certamente – impatti su vari territori. Un anno molto interessante, in tal senso, è stato il 2011: in Australia ad esempio è stato caratterizzato da fortissimi inondazioni alternate ad una fortissima siccità. L’Australia, che ha uno Stato forte, è riuscita a contenerne gli effetti entro una dinamica ordinata. Nello stesso anno ci sono stati dei paesi che non sono stati colpiti direttamente dai cambiamenti climatici (parlo di quelli della sponda sud del Mediterraneo) ma ne hanno subito gli effetti indiretti perché questi hanno fatto aumentare i prezzi dei prodotti agricoli (quei paesi ne importano molti) e si è venuta a creare molta povertà. Questa situazione è stata all’origine delle ‘primavere arabe’. L’Italia, che è il paese più esposto, non mi sembra si stia curando troppo di questo tema. Al momento è difficile andare ad identificare una sola motivazione: la causa unica di migrazione relativa al cambiamento climatico per ora si verifica in sparute situazioni».
Ad esempio quali?
«I primi rifugiati climatici ufficiali vengono dagli Stati Uniti: a causa della fusione del permafrost in Alaska, che destabilizza le fondamenta fisiche delle comunità, si sono dovute muovere delle persone. Oltre che dall’Artico, iniziano anche a venire dalle isole».
È notizia di questi giorni, a tal proposito, la denuncia degli abitanti delle Isole dello Stretto di Torres che hanno denunciato il governo australiano. Anche questo potrebbe rientrare in possibili situazioni che genererebbero ‘rifugiati climatici’?
«Questi sono i primi ‘movimenti climatici’. Se andiamo nelle cose che ci riguardano più da vicino, che sono più consistenti e dove l’impatto del clima è intessuto con altre forme di instabilità, è molto difficile dare un’etichetta all’uno o all’altro. Quello su cui si deve fare chiarezza è che non esiste affatto il ‘migrante climatico’».
Perché?
«Perché ‘migrante’ è qualcuno che ha un minimo di scelta libera nella decisione di muoversi e non è vero che quanto più si è poveri tanto più si è propensi a muoversi. Al di sotto di una certa fascia di reddito si rimane intrappolati in quella che viene definita la ‘trappola della povertà’: hai, cioè, un reddito talmente basso che ti è impossibile partire e la migrazione non rientra fra le tue prospettive; la tua unica urgenza è dettata dalla necessità di reperire un pasto per la giornata e ti è impossibile perfino pianificare di andare al villaggio più vicino. Quando si verifica un evento ambientale che può destabilizzare una situazione già precaria, se colpisce coloro che già si trovano nella fascia di quelli che contemplano una migrazione generalmente può essere assorbito da essi: posseggono, cioè, risorse a sufficienza da sopperire ad un mancato raccolto. Se sono sufficientemente ricchi da contemplare una migrazione volontaria, sono anche sufficientemente ricchi per assorbire delle fluttuazioni del clima. In realtà colpisce, generalmente, quelli che si trovano nella ‘trappola della povertà’, dunque non crea migrazioni ma movimenti forzati ed è una cosa completamente diversa».
>>Leggi anche: Il cambiamento climatico investe culture e geopolitica<<
Cioè?
«I movimenti forzati si distinguono dalle migrazioni perché le prime, se ben gestite, possono essere utili per la zona di provenienza, per chi parte e per la zona di arrivo. D’altra parte, invece, se si mette in movimento qualcuno che non ha alcuna ‘difesa’ costoro si tramutano in combustibile per movimenti fanatici, per il traffico illecito, per la criminalità: sono situazioni destabilizzanti e nocive per tutti. L’insegnamento di Madre Terra è che bisogna occuparsi primariamente dei più poveri altrimenti ‘pagano’ tutti».
Che giudizio dà a proposito delle due mozioni sull’emergenza climatica in Regno Unito e in Irlanda? Auspica che altri Parlamenti facciano altrettanto?
«Per me il valore maggiore di questi atti non è la cogenza ma la presa di coscienza e spiego il perché: nel 301 d.c. l’imperatore Diocleziano si trovò di fronte ad un’inflazione incontrollata e gli venne in mente di istituire ciò che oggi chiameremmo ‘il calmiere’ [l’ Edictum de pretiis n.d.r.]. Ufficialmente i prezzi non salirono più ma il vero risultato che ottenne è che il mercato si spostò su quello nero. Quello che voglio dire è che il cambiamento climatico non si risolve per decreto legge ma con la mobilitazione dell’intera società. Tra l’altro è una mobilitazione che paradossalmente non avviene massivamente: qualsiasi atto di sostenibilità porta sia più benessere che più ricchezza. Una mobilitazione collettiva significherebbe disinnescare il cataclisma pagando il prezzo di stare meglio».
Dagli strati più poveri al benessere di tutti, insomma.
«Ma non solo occupandosi, direttamente e unicamente, di strati svantaggiati: lo si fa anche occupandosi di se stessi. Se pensi alla tua vita vita quotidiana e decidessi di nutrirti, lavarti e muoverti in maniera più salutare, lo fai per te stesso: stai creando sostenibilità nella misura in cui rispetti la tua vera natura, tutto ciò che è salutare è anche sostenibile.
Salutare, ovviamente, va inteso a 360 gradi: se scegli di muoverti in maniera sostenibile generalmente spendi di meno e non solo hai più salute ma hai anche spazi di socializzazione migliore. Questo discorso che vale per ogni individuo vale anche per l’impresa».
In che modo?
«Le imprese si stanno accorgendo che hanno tutto da guadagnare ad essere sostenibili, tant’è che i più cattivi dei cattivi dell’economia, cioè la finanza, hanno spostato gli impieghi di investimento sulle cosiddette attività sostenibili (tecnicamente si chiamano ESG) dallo 0,2% al 24% in 10 anni: un progresso enorme. Parallelamente stanno puntando ad avere il 60% dei loro portafogli su attività sostenibili entro breve: non sto parlando di Banca Etica ma di Blackrock! Quello che noi dobbiamo innescare lo dobbiamo fare certamente anche con l’apporto e l’appoggio istituzionale, legislativo e fiscale ma quello da solo, se non è recepito e compreso dalla società, diventa una distorsione».
Come si fa a fare in modo che venga percepito da tutti?
«Bisogna far toccare con mano la questione viva. Le imprese hanno un vantaggio su tutti, dunque lo hanno compreso e si stanno muovendo rapidamente in tal senso.
Dobbiamo sovvertire la narrativa tradizionale, paradossalmente, che vede l’economia cattiva verso un pubblico buono, per dirla in maniera molto semplice: non è questione di essere buoni o cattivi ma il consumatore ancora non ha interiorizzato i benefici della sostenibilità dal punto di vista delle proprie scelte consapevoli. Esco per un attimo dai binari dell’argomento principale ma completo quanto sto dicendo: abbiamo pochissimo tempo per rimediare, al massimo dieci anni. Purtroppo non possiamo contare su una totale presa di consapevolezza collettiva che porti a delle scelte di cambiamento volontario e coerente. L’essere umano difficilmente reagisce all’interesse collettivo ma a quello individuale: si sa che soltanto il 2% dei consumatori (e questo è un dato transculturale) incorporano la loro domanda di consumo sostenibile e tipicamente costoro sono i clienti del commercio equo e solidale.
Botteghe importanti ma anche simboliche: rappresentano una fascia minuscola del mercato. Questo non vuol dire che si tratta di una battaglia persa perché sta succedendo qualcosa: oggi la sostenibilità non si compra perché ‘salva il Mondo’ ma perché il prodotto è migliore. Nel settore del turismo la questione è evidente: dieci anni fa l’attività più ricercata era il ‘Resort all inclusive’, altamente insostenibile, dove il grande lusso la faceva da padrone; oggi l’attività più ricercata è quella che ti porta in condizioni di scomodità, in un nugolo di zanzare, a vivere da vicino la natura incontaminata. Tornando al cibo: non possono permetterselo tutti, ma moltissimi consumatori, se potessero, si orienterebbero verso il biologico e il non-industriale. Qui la tempistica ci pone un problema di scala, nel senso che la volontà ci sarebbe ma per ora sono mercati per fasce ricche e bisogna incoraggiarle – paradossalmente – perché facendo in modo che essi comprino creano quell’economia di scala che poi consente di allargare l’accessibilità anche alle fasce più povere e lo si è visto in Germania in cui il biologico era appannaggio dei più ricchi ed ora è accessibile di tutti».
Orientarsi più su questo, dunque, che non sugli atti politici?
«Certamente ma non dico che non servono, anzi: segnalano l’unitarietà della società e la consapevolezza in tal senso che è l’unico fattore che può cambiare le cose per tempo. Allo stesso modo un trattato, una legge, un provvedimento fiscale è carta. E la natura non reagisce ai pezzi di carta».
>>Leggi anche: Le guerre di oggi sono causate dal cambiamento climatico?<<