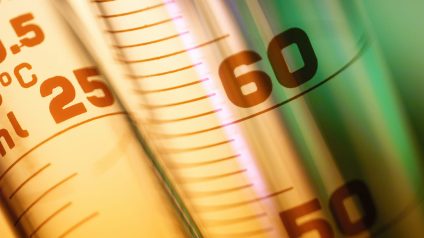Gli attori dell’industria sciistica tendono a pensare che i loro problemi e le soluzioni da proporre siano più legati alla “percezione sociale” – la domanda sempre forte di vacanze sulla neve – che alla crisi climatica. Questo determina il tipo di risposte messe in campo: si spara neve artificiale per adattare il business alla domanda di mercato, non al clima che sta cambiando

Lo studio dell’università di Vienna pubblicato su New Political Economy
(Rinnovabili.it) – Tutti gli studi scientifici dicono che sulle Alpi nevica sempre di meno e il manto nevoso si scioglie prima. E sarà sempre peggio nei prossimi anni. Ma buona parte dell’industria della neve continua a investire in impianti di risalita, neve artificiale, bacini di accumulo per produrla. La linea di affidabilità della neve si alza inesorabilmente, e con lei anche la quantità di risorse economiche – spesso pubbliche: il ministero del Turismo italiano ha previsto 200 mln euro nel 2023-2026 – necessarie per tenere in vita il settore.
Perché la maggior parte dell’industria della neve si comporta così? Cosa pensa della crisi climatica chi investe ancora oggi nello sci? Che idea ha dell’economia, della crescita, della transizione, delle misure di adattamento al cambiamento climatico? A queste domande inizia a rispondere uno studio dell’università di Vienna pubblicato ieri su New Political Economy che si basa su interviste dirette a 22 protagonisti dell’industria sciistica in una parte di Alpi più legata allo sci, sul versante austriaco.
L’industria della neve “non guarda in alto”
Le voci di chi sta investendo nello sci alpino guardano al motore della crescita – oggi inceppato – come una questione di “percezione sociale” piuttosto che di crisi climatica. Il climate change, per loro, è un rischio di transizione e non un rischio fisico. Cosa significa?
Questi termini sono usati dalla Banca centrale europea per gli stress test sulla resilienza al riscaldamento globale del sistema bancario UE. Per la BCE il rischio fisico deriva dall’aumento della frequenza e dell’entità dei disastri climatici, mentre il rischio di transizione esprime l’impatto negativo che potrebbe derivare da politiche climatiche per ridurre le emissioni di gas serra.
L’industria dello sci, suggerisce lo studio, pensa che pompare sempre più denaro (e neve artificiale) sia l’unica risposta possibile perché vede solo la “pressione dei consumatori” come driver della situazione di oggi. Se la crisi climatica fosse vista come un rischio fisico, invece, “richiederebbe adattamento e mitigazione”. Il punto è che il clima che cambia è anche un rischio fisico.
Detta in altre parole, l’industria della neve si comporta come i leader mondiali in “Don’t look up”: non vedono l’asteroide ma un enorme giacimento di minerali preziosi che possono sfruttare o lasciarsi sfuggire. Cioè ragionano con gli stessi schemi mentali anche quando la situazione reale richiederebbe uno sguardo diverso.
Da qui lo strabismo di lottare a suon di milioni di euro contro un fenomeno inesorabile replicando le stesse modalità di sempre: la montagna frutta denaro grazie alla neve e alla sua fruizione secondo certe modalità precise, quindi se c’è sempre meno neve la soluzione non può che passare dal creare nuova neve. E restare a galla finché le cose non si stabilizzano.
È un atteggiamento che “disaccoppia il cambiamento climatico dal mantenimento del motore della crescita” e consente ai protagonisti dell’industria dello sci di ragionare sulla base di “strategie di legittimazione” fondate su un mero calcolo dei costi economici che deriverebbero dal modificare strutturalmente i loro servizi, e dei costi culturali che rappresenterebbe uno stravolgimento dell’identità locale e regionale. La risposta alla crisi climatica attraverso misure di adattamento e mitigazione, quindi, non è visto come qualcosa che ha a che fare con il mantenimento della crescita economica.